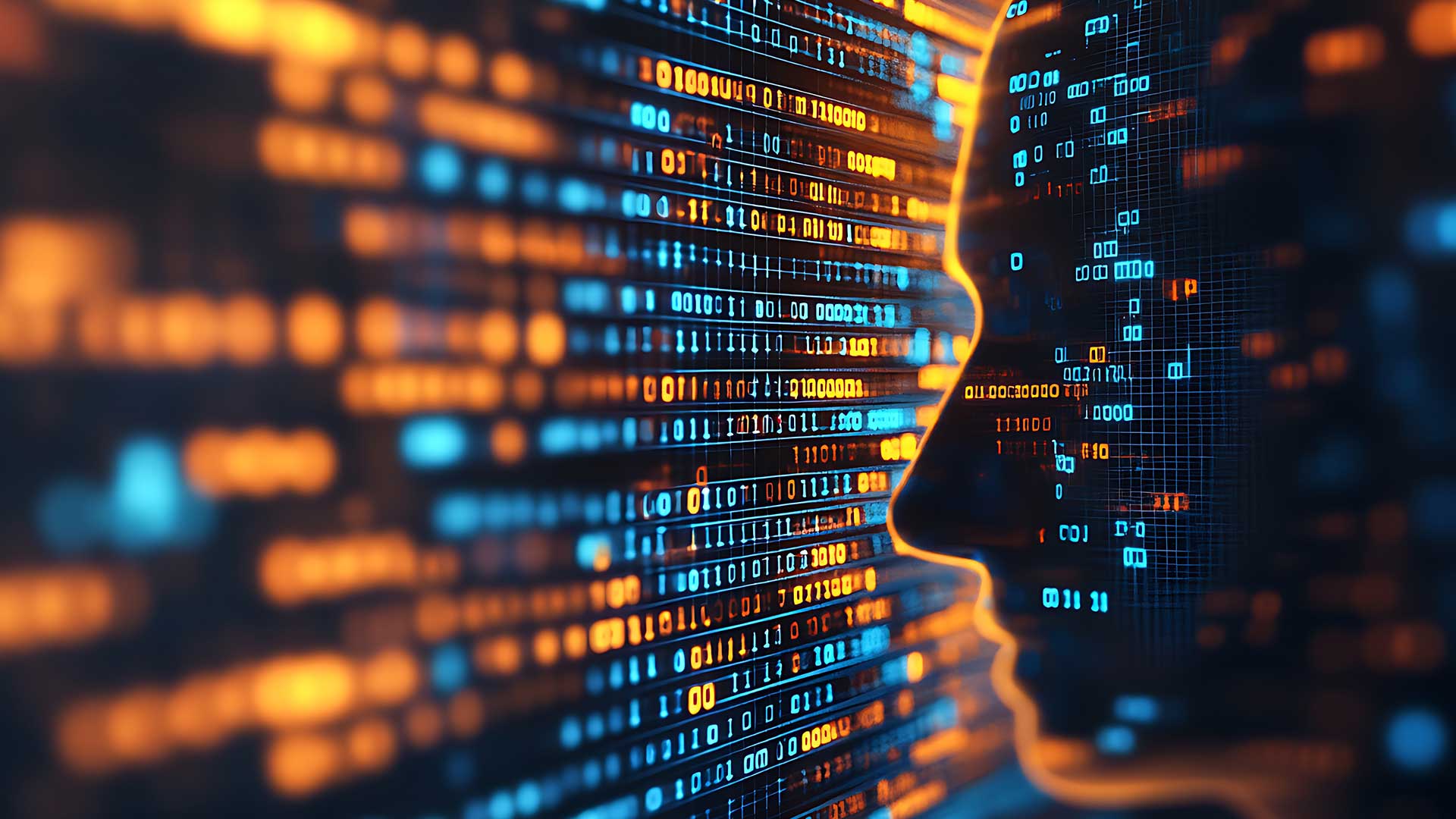Smart city e sorveglianza algoritmica: un binomio che sembra destinato a plasmare il futuro delle nostre comunità urbane. Con il progresso incessante delle tecnologie digitali, sensori e reti neurali distribuite, le città intelligenti promettono una gestione più razionale delle risorse, un traffico più scorrevole, una riduzione dell’inquinamento, una risposta rapida alle emergenze. Ma questo scenario di apparente progresso si intreccia in modo inestricabile con la questione dei diritti civili, della privacy e della libertà individuale, tanto da spingerci a riflettere se non stiamo sacrificando silenziosamente un pilastro fondamentale delle democrazie moderne sull’altare dell’efficienza algoritmica.
Una smart city si fonda su infrastrutture digitali pervasive: telecamere intelligenti capaci di riconoscere volti, targhe, movimenti sospetti; sensori che monitorano costantemente la qualità dell’aria, i consumi energetici, i livelli acustici. I dispositivi IoT installati in semafori, lampioni, autobus, cassonetti dei rifiuti dialogano tra loro e con grandi piattaforme di analisi predittiva. Così facendo, riescono a ottimizzare i percorsi della raccolta differenziata, regolare in tempo reale i flussi del traffico, prevenire guasti agli impianti idrici ed elettrici. Questo è il lato seducente del paradigma: una città che si autogestisce, che riduce sprechi e inefficienze, che sembra persino anticipare i bisogni dei cittadini.
Ma sotto la superficie di questa razionalizzazione tecnologica si cela un’infrastruttura di controllo algoritmico che ridisegna il rapporto tra individui e potere pubblico. Oggi, la sicurezza urbana viene sempre più affidata a sistemi automatizzati di videoanalisi comportamentale e riconoscimento facciale. In molte metropoli asiatiche ed europee, algoritmi addestrati su milioni di immagini identificano soggetti che «deambulano in modo anomalo» o che si soffermano troppo a lungo in aree ritenute sensibili. Questi stessi sistemi possono generare alert in tempo reale alle forze dell’ordine, che intervengono sulla base di un rischio stimato da una macchina. Qui il confine tra prevenzione e profilazione diventa labile, e il principio di presunzione di innocenza rischia di essere scavalcato da un calcolo probabilistico.
Il problema si complica se consideriamo che tali algoritmi non sono infallibili: ereditano i bias dei dati con cui sono addestrati. Numerosi studi accademici hanno dimostrato come i sistemi di riconoscimento facciale abbiano margini di errore molto superiori quando si tratta di persone con pelle scura o di donne rispetto agli uomini bianchi. Questo implica che, in un contesto di sorveglianza automatizzata, interi segmenti della popolazione rischiano di essere discriminati o ingiustamente attenzionati. Lungi dall’essere un difetto tecnico facilmente correggibile, questo aspetto mette a nudo una criticità profonda: gli algoritmi non vivono nel vuoto, ma riflettono e amplificano le asimmetrie già presenti nella società.
Non è solo una questione di polizia predittiva o di telecamere intelligenti. L’ecosistema smart city comprende anche piattaforme di social scoring, schede digitali sanitarie e strumenti di monitoraggio del consumo domestico. A Shanghai e in altre città pilota, il credito sociale valuta i cittadini sulla base di comportamenti ritenuti virtuosi o problematici, incidendo sulla possibilità di accedere a mutui, lavori pubblici o persino di prenotare viaggi. In alcuni Paesi occidentali, sebbene non esista un sistema formalizzato di punteggio sociale, le banche, le compagnie assicurative e i datori di lavoro possono comunque utilizzare big data per profilare i soggetti e prendere decisioni che impattano la vita economica e professionale delle persone.
Dietro la retorica della città efficiente e sostenibile si annida dunque il rischio di una deriva panottica, dove ogni gesto viene tracciato, registrato e potenzialmente valutato. I big data diventano la nuova linfa del potere, ma il cittadino non ne controlla né la raccolta né l’elaborazione. Chi stabilisce quali comportamenti siano «normali» o «devianti»? Chi garantisce che i dati non vengano ceduti a terzi, a piattaforme pubblicitarie o a enti governativi con finalità opache? Chi tutela i soggetti più vulnerabili, spesso privi degli strumenti culturali e giuridici per opporsi a un algoritmo che decide del loro destino?
Il diritto alla privacy, sancito da Costituzioni e carte sovranazionali, si fonda sull’idea che la persona abbia uno spazio inviolabile in cui sviluppare la propria individualità e autodeterminazione. Ma la sorveglianza algoritmica rischia di erodere questo spazio, trasformandoci in corpi trasparenti, permanentemente esposti allo sguardo di un sistema informatico. Persino la libertà di manifestare opinioni politiche o di partecipare a proteste potrebbe essere scoraggiata dalla consapevolezza di vivere sotto una cappa di occhi digitali, in grado di ricostruire i nostri spostamenti e contatti sociali.
Non mancano certo le argomentazioni a favore di tali tecnologie. In tempi di crisi sanitaria globale, come la recente pandemia da COVID-19, sistemi di contact tracing e di monitoraggio dei movimenti hanno consentito di limitare i contagi e salvare vite umane. In contesti di emergenza criminale, la possibilità di identificare rapidamente un sospetto tramite telecamere e database può risultare cruciale. Tuttavia, la questione centrale rimane quella della proporzionalità e della trasparenza democratica: siamo disposti a concedere a un sistema informatico il diritto di vigilare costantemente su di noi in cambio di una maggiore sicurezza? E chi controlla chi controlla?
La governance delle smart city dovrebbe prevedere strumenti di accountability rigorosi, organi indipendenti che vigilino sull’uso dei dati, processi di auditing sugli algoritmi, e la possibilità per i cittadini di opporsi alle decisioni automatizzate che li riguardano. Le norme sul GDPR europeo rappresentano un primo argine, ma spesso si concentrano più sul consenso formale alla raccolta dei dati che sulla reale possibilità per l’individuo di incidere sui processi decisionali automatizzati. Il diritto alla spiegazione, introdotto dal regolamento europeo, è un passo importante ma ancora poco praticato: sapere perché un algoritmo ha negato un prestito o ha allertato la polizia non è sempre facile, soprattutto quando gli stessi creatori dei modelli non sono in grado di spiegare il funzionamento interno delle reti neurali profonde.
In definitiva, la partita tra efficienza e diritti civili si gioca sul terreno dell’equilibrio. Non si tratta di demonizzare le tecnologie smart, ma di governarle con lungimiranza, imponendo limiti chiari e salvaguardie effettive. Una smart city che voglia dirsi veramente «intelligente» dovrebbe puntare non solo sull’ottimizzazione logistica e ambientale, ma anche sul potenziamento della cittadinanza attiva, sulla partecipazione consapevole dei residenti ai processi decisionali, sul diritto all’anonimato quando non sussistono esigenze specifiche di sicurezza.
Nel contesto globale, la sfida è ancora più complessa. Modelli autoritari, che vedono nella sorveglianza capillare uno strumento di stabilità politica e sociale, stanno guadagnando terreno e offrono una narrazione persuasiva ai governi in difficoltà. Anche in Europa, il rischio di normalizzare pratiche invasive si fa sentire, specialmente dopo episodi di terrorismo o crisi sanitarie che giustificano stati di eccezione. Da temporanee misure di emergenza si passa così a regimi permanenti di controllo, in un lento ma inesorabile slittamento che i costituzionalisti conoscono fin troppo bene.
Riconoscere la posta in gioco significa anche promuovere una nuova alfabetizzazione digitale, che renda i cittadini consapevoli dei propri diritti, dei meccanismi tecnici alla base della raccolta e analisi dei dati, e dei modi concreti per esercitare un controllo sulle proprie informazioni personali. Senza questa maturità collettiva, le smart city rischiano di diventare trappole dorate, dove la comodità e l’efficienza si pagano con la rinuncia progressiva a libertà che i nostri padri e nonni hanno conquistato con dure lotte.
Per questo serve un dibattito pubblico ampio, che coinvolga non solo giuristi, ingegneri e amministratori, ma anche cittadini comuni, associazioni, scuole, media indipendenti. Il futuro delle nostre città e dei nostri diritti si deciderà nei prossimi decenni, e non possiamo permettere che decisioni tanto rilevanti vengano prese nel chiuso di server farm o consigli d’amministrazione. Una smart city etica è possibile, ma richiede coraggio politico, innovazione giuridica e una vigilanza civile costante, perché la tecnologia resti uno strumento al servizio dell’uomo, e non il contrario.