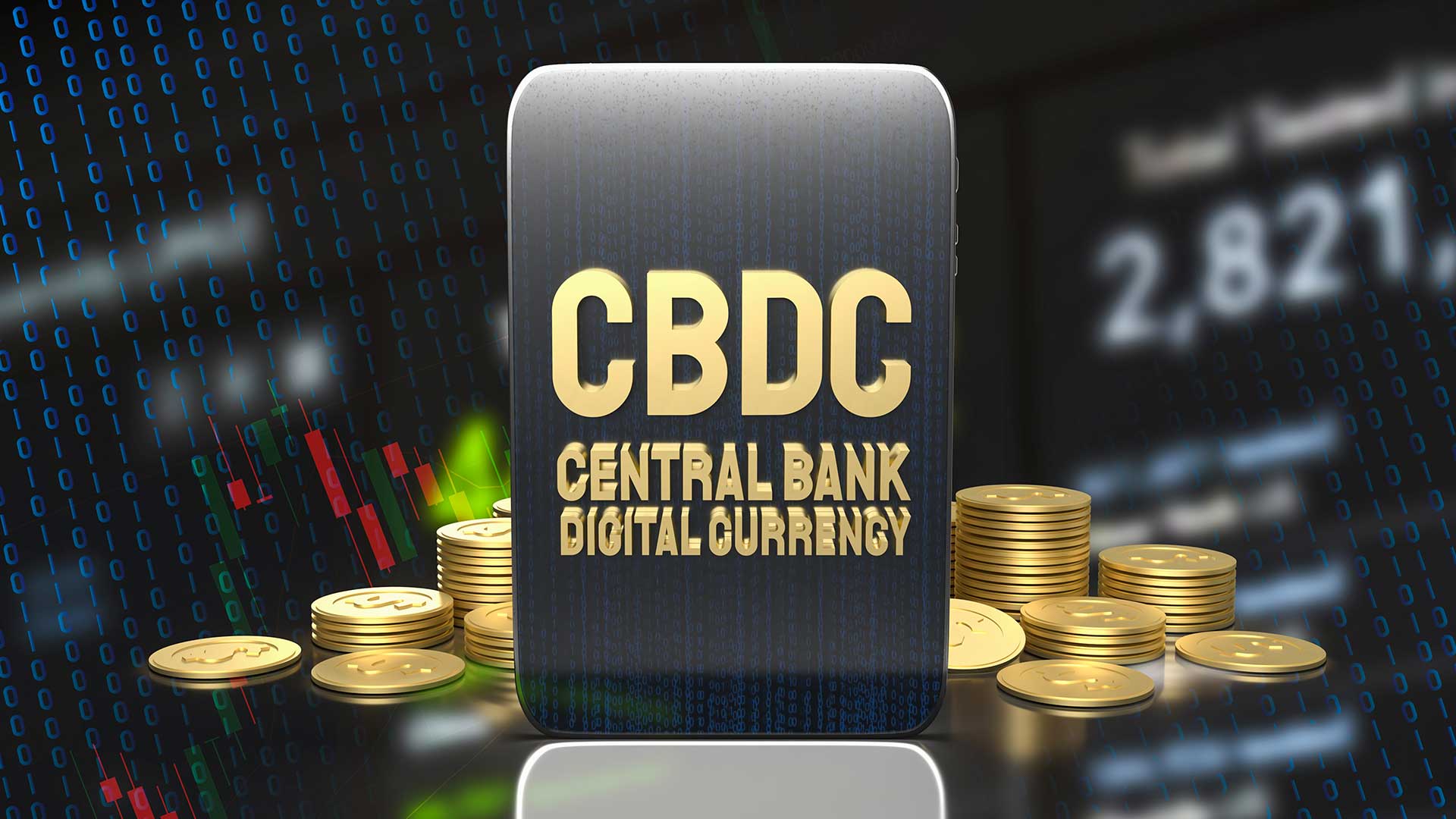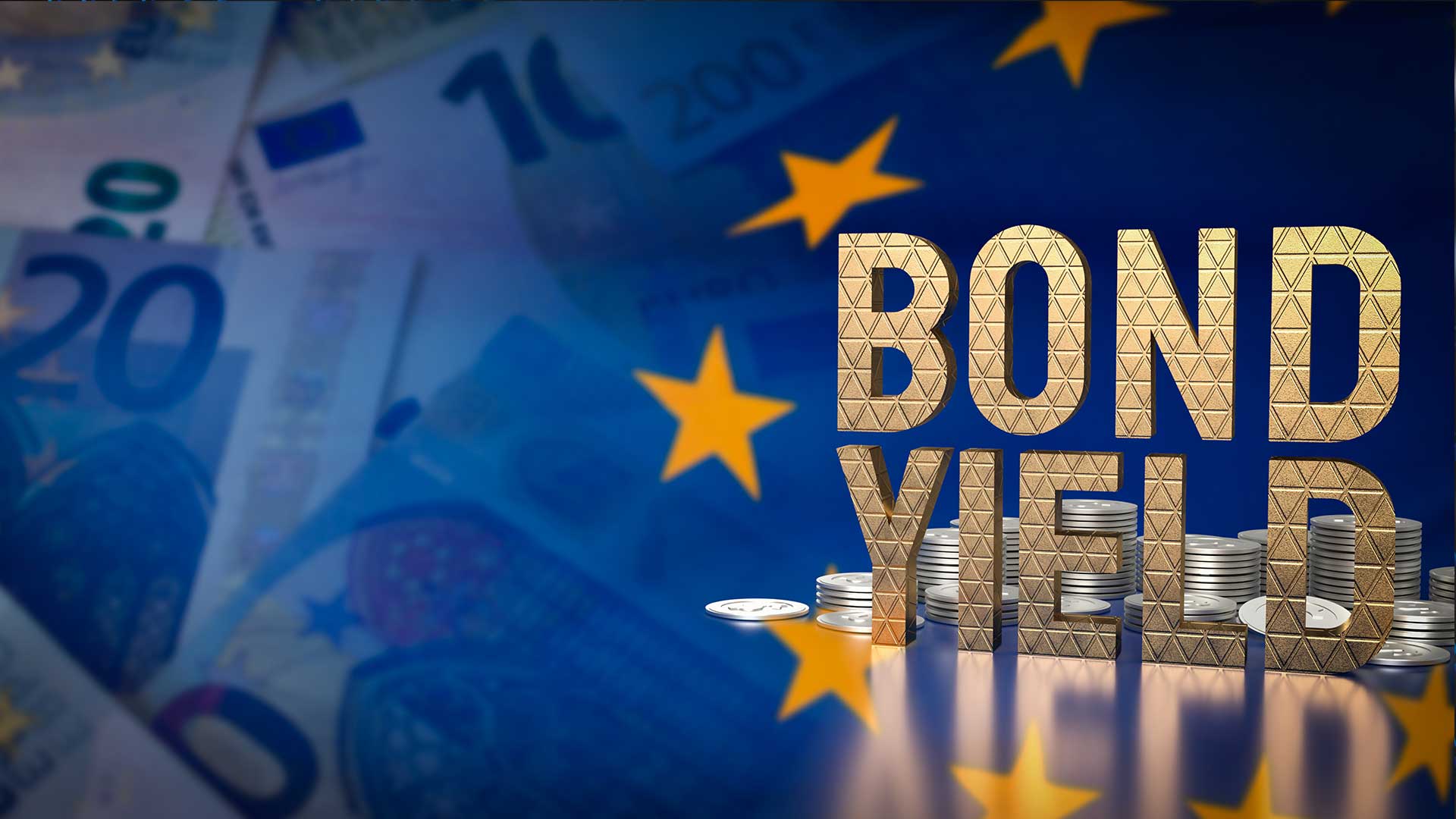Il Giappone, a lungo percepito come un corpo estraneo nel sistema capitalistico occidentale, è oggi il cuore pulsante di una minaccia latente, silenziosa, ma sempre più imminente. L’apparente equilibrio che tiene in piedi la sua economia stagnante e il suo debito pubblico fuori scala potrebbe rivelarsi un castello di carte pronto a crollare al primo soffio di vento internazionale. Mentre i riflettori dei media economici sono spesso puntati sugli Stati Uniti, sulla Cina o sulle crisi emergenti, è nel Paese del Sol Levante che si cela la faglia sismica di una potenziale crisi globale.
Per comprendere la portata di questo rischio, bisogna tornare indietro nel tempo. Era il 1992 quando il Giappone fu travolto dall’esplosione della bolla immobiliare, evento che segnò l’inizio di quello che verrà poi definito come il “decennio perduto”. Tuttavia, la perdita si è dilatata nel tempo, diventando un inverno economico che dura ancora oggi. In risposta al collasso del valore degli asset e alla paralisi del sistema finanziario, il governo nipponico scelse di reagire con uno strumento che da lì in poi sarebbe diventato il pilastro instabile della sua sopravvivenza economica: l'indebitamento pubblico.
Anno dopo anno, attraverso politiche fiscali espansive, il Giappone ha pompato liquidità nell’economia per stimolarne la ripresa. Ma la crescita non è mai realmente arrivata. A fronte di un PIL stagnante, il rapporto debito/PIL ha cominciato una corsa verso l'alto fino a superare il 250%. Un livello che, in qualsiasi altra economia avanzata, avrebbe già portato a una crisi di solvibilità. Il motivo per cui questo non è accaduto risiede in un segreto sistemico: oltre il 90% del debito pubblico giapponese è detenuto da soggetti interni, molte volte legati o controllati dallo Stato stesso.
Questo particolare assetto ha garantito stabilità apparente, ma ha anche alimentato un pericoloso senso di impunità macroeconomica. Con l'avvento di Shinzō Abe nel 2012, il Giappone ha tentato una svolta, elaborando la celebre strategia delle "tre frecce" dell'“Abenomics”: politica monetaria ultra-espansiva, stimolo fiscale e riforme strutturali. Ma mentre la Banca Centrale del Giappone azzerava i tassi e iniettava massicce dosi di liquidità, le altre due frecce rimanevano incoccate. Le riforme non arrivavano, e lo stimolo fiscale, ancorato al debito, diventava insostenibile. L'economia non reagiva. Il mercato interno continuava a spegnersi. E il carry trade, ovvero il finanziamento globale alimentato da prestiti in yen a tasso zero, diventava il carburante sottile di una finanza globale drogata da eccesso di leva.
Il meccanismo è tanto semplice quanto micidiale: si prende denaro in prestito in Giappone a tassi bassissimi, lo si cambia in dollari o euro, e si investe in obbligazioni estere ad alto rendimento. Finché lo yen resta debole e i tassi giapponesi restano bassi, il sistema regge. Ma se cambia lo scenario monetario interno, tutto può collassare. Ed è proprio quello che sta iniziando ad accadere.
Con l’esplosione dell’inflazione globale tra il 2022 e il 2024, anche il Giappone è stato costretto a cambiare rotta. La Banca Centrale ha cominciato ad alzare i tassi. La prima conseguenza è stata la morte del carry trade. Gli investitori globali non trovano più conveniente finanziarsi in yen. Iniziano a ritirarsi, a vendere titoli, a uscire da posizioni di leva costruite su sabbie mobili. E il mercato globale, abituato a contare su quella linfa giapponese, si ritrova improvvisamente a corto di ossigeno.
Ma non è solo un problema di flussi finanziari. È un problema sistemico. Il Giappone è uno dei principali acquirenti di titoli di stato americani. Se Tokyo, per necessità interne, dovesse ridurre i propri acquisti, o peggio iniziare a vendere, il rischio è un crollo dei bond USA, con una reazione a catena sui tassi, sull’indebitamento globale, sul valore stesso del debito come asset sicuro. Sarebbe l'inizio di un reset finanziario mondiale.
Il tutto è aggravato da una realtà demografica impietosa. Il Giappone è il paese più vecchio del mondo. La forza lavoro si riduce, le pensioni crescono, il carico fiscale diventa insostenibile. La propensione al consumo crolla, i risparmi si accumulano, ma non vengono investiti. Una società in decrescita esistenziale non può sostenere una crescita economica stabile. Questo squilibrio interno, unito al peso del debito e all'impatto globale delle sue dinamiche finanziarie, fa del Giappone il possibile epicentro di una nuova crisi sistemica.
Ciò che rende il tutto più pericoloso è che questo rischio è ancora largamente sottovalutato. I mercati continuano a trattare il Giappone come una anomalia gestibile. Ma i segnali sono chiari: aumento dei tassi, perdita di fiducia, deflusso di capitali, disgregazione dell’architettura del carry trade. E se un giorno gli investitori internazionali decidessero di disfarsi dei titoli giapponesi? Il valore dello yen crollerebbe, i tassi volerebbero, il debito diventerebbe insostenibile. Un default ordinato o disordinato, poco cambia: l'effetto domino sarebbe devastante.
Perché la crisi giapponese è diversa dalle altre? Perché non è una crisi esplosiva, è una crisi implosiva. Non arriva con il boato, ma con il silenzio. Come un vuoto che si espande finché non assorbe tutto ciò che lo circonda. Un'economia che non cresce, ma nemmeno muore, un sistema che non fallisce, ma nemmeno si rigenera. Un’agonia lunga trent'anni che ora rischia di portare con sé anche il resto del mondo.
L'Occidente dovrebbe imparare dal Giappone. Dovrebbe osservare quell'insieme di decisioni sbagliate, riforme mancate e dipendenze finanziarie pericolose. Perché quello che accade oggi a Tokyo, domani potrebbe accadere a Washington, a Bruxelles, a Roma. L'economia globale è interconnessa, e ogni squilibrio strutturale, se ignorato, può diventare un evento sistemico. Il Giappone non è più solo il paese dell’hikikomori e dell’età d’oro perduta: è il termometro del futuro finanziario del mondo. Un futuro che, se non verrà corretto ora, rischia di presentare un conto salatissimo.
Ecco perché oggi, più che mai, dobbiamo guardare verso Oriente non per trovare modelli, ma per riconoscere segnali d'allarme. Perché dal cuore pulsante dell'Asia potrebbe partire il prossimo shock globale. Non sarà una tempesta violenta, ma una pioggia sottile e costante che scava nella roccia fino a frantumarla. Ed è proprio questa apparente normalità che rende tutto ancora più pericoloso.