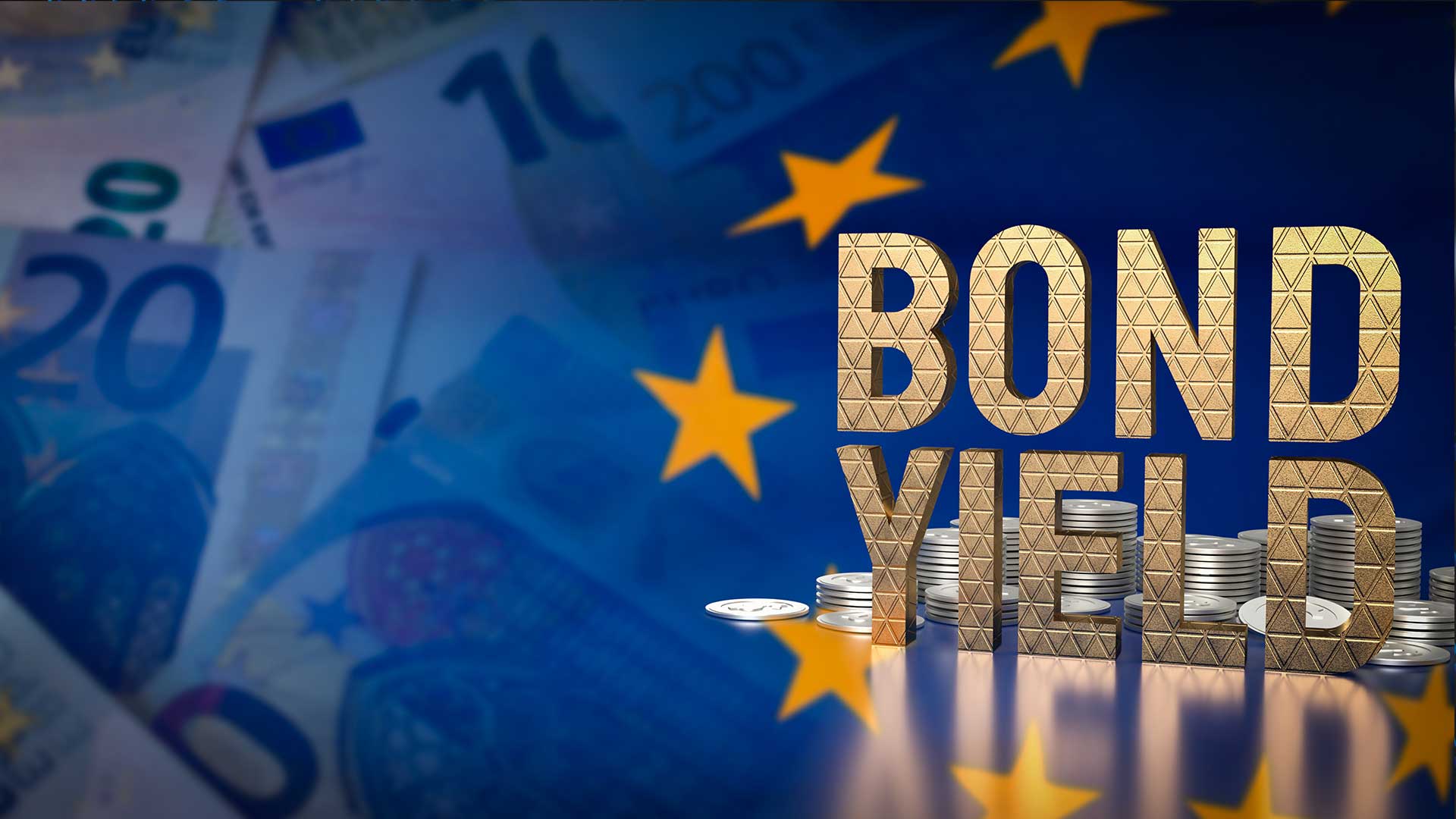Nel grande racconto della finanza globale, ogni tanto emerge un personaggio silenzioso, un comprimario che sembrava marginale e che invece si rivela essere il centro invisibile della scena. Così è il Giappone. Non più al centro delle cronache economiche come ai tempi del suo boom tecnologico, eppure oggi più centrale che mai. Perché mentre il mondo si concentra sulle tensioni tra Stati Uniti e Cina, sull’inflazione post-pandemica, sulla transizione energetica e sull’intelligenza artificiale, nelle viscere statiche dell’economia giapponese sta maturando una crisi che potrebbe diventare il terremoto sistemico della nostra epoca. E non per eccesso di rumore, ma per assenza di movimento. Non per un'esplosione, ma per un’implosione.
Chi osserva il Giappone con superficialità rischia di coglierne solo le apparenze. Una nazione ricca, ordinata, pacifica. Ma sotto questa calma si nasconde una pressione finanziaria e sociale crescente, una serie di dinamiche interconnesse che lo rendono un sorvegliato speciale nei bilanci della storia. Il suo debito pubblico monstre, superiore al 250% del PIL, è solo il sintomo più evidente di un malessere più profondo. Un malessere che tocca la struttura demografica, la domanda interna, il modello produttivo, la politica monetaria e l’intero sistema di fiducia collettiva su cui si regge ogni ordine economico.
Non stiamo parlando di una crisi esplosiva, di quelle che si manifestano in default, bancarotte o rivolte. Stiamo parlando di una crisi sussurrata, che da trent’anni accompagna il Giappone e che oggi rischia di diventare contagiosa. Perché la sua anomalia, un tempo isolata e gestibile, è diventata una variabile di sistema. E se il Giappone cade, lo fa trascinando con sé pezzi di mondo che da lui dipendono in modo invisibile ma strutturale.
Nel corso degli anni, il Giappone ha adottato politiche economiche sempre più ardite per compensare la sua stagnazione cronica. Dalla celebre “Abenomics” alle politiche monetarie ultra-espansive della Banca Centrale, il Paese ha costruito un modello di sopravvivenza artificiale. Ha continuato a immettere liquidità, a mantenere i tassi d’interesse negativi, a comprare titoli pubblici con strumenti di politica monetaria non convenzionale. E nel frattempo, è diventato il grande prestatore silenzioso della finanza globale: tramite il famigerato carry trade, miliardi di yen hanno finanziato debito pubblico e corporate bond in tutto il mondo, dalla Thailandia alla California.
Ma questo motore occulto della liquidità globale si è inceppato. Con il ritorno dell’inflazione mondiale e la necessità di rialzare i tassi, anche il Giappone è stato costretto a interrompere il gioco della moneta gratuita. Il risultato è devastante. Non solo per la sua economia interna, che non è in grado di reggere un rialzo dei tassi senza esplodere nei suoi squilibri fiscali. Ma anche per il mondo, che improvvisamente si ritrova senza quella fonte nascosta di denaro a basso costo che ha lubrificato la finanza internazionale per vent’anni.
L’impatto è doppio: da una parte il crollo del carry trade, dall’altra la fine della funzione giapponese come detentore di debito globale. Non è un dettaglio. Il Giappone è uno dei maggiori possessori di titoli di stato americani. Se, per esigenze interne, inizia a vendere quei titoli, o semplicemente smette di comprarli, i mercati mondiali dovranno reagire. Con un aumento dei rendimenti, una stretta creditizia e un rischio sistemico a cascata. È il paradosso dell’interdipendenza: un paese che non cresce può comunque causare il collasso dell’intero sistema.
Ma la crisi giapponese non è solo economica. È demografica, sociale, psicologica. È una crisi dell’immaginario. In una società dove la popolazione invecchia più velocemente di qualsiasi altra, dove il tasso di natalità è tra i più bassi al mondo, dove i giovani non credono più nel futuro e gli anziani vivono di risparmio e previdenza, si spegne la fiamma vitale dell’economia: la fiducia. Non c’è crescita senza desiderio, non c’è investimento senza aspettativa, non c’è consumo senza prospettiva. E in Giappone, da troppo tempo, è venuto meno il senso collettivo del domani.
Le famiglie giapponesi risparmiano ossessivamente. Non per progettare, ma per difendersi. Tengono la liquidità ferma nei conti, o investita in asset statici. Non rischiano, non consumano, non innovano. E così il mercato interno si contrae, le imprese si spengono, lo Stato si indebita per tenere in vita un corpo economico che non reagisce. È una deflazione dell’anima, ancor prima che dei prezzi. Un’economia che non muore, ma che non vive più. E questa stagnazione, seppur silenziosa, è letale. Perché non fornisce più risorse al sistema, ma ne assorbe. Non produce slancio, ma zavorra l’architettura finanziaria globale.
Nel frattempo, la Banca Centrale del Giappone si trova stretta in una trappola perfetta. Se continua a mantenere i tassi bassi, rischia di alimentare l’inflazione e di compromettere la stabilità dei risparmiatori. Se li alza, aumenta il costo del debito e rischia di far saltare il fragile equilibrio fiscale. Qualunque mossa implichi un sacrificio. Ma qualunque immobilismo implica un declino. È la condizione estrema del sistema: una crisi in cui nessuna opzione è davvero praticabile.
La lezione giapponese non è solo un caso da manuale. È un avvertimento al mondo. Perché molte economie avanzate stanno entrando in una dinamica simile: debito crescente, popolazione in calo, consumi stagnanti, fiducia frammentata. E il rischio è che ciò che oggi vediamo in Giappone sia solo l’anticipazione di un destino condiviso. La crisi che lì ha impiegato trent’anni per maturare, altrove potrebbe manifestarsi molto più rapidamente, proprio a causa dell’interconnessione tra sistemi finanziari e catene di valore.
In questa serie di articoli, esploreremo in profondità tutte le dimensioni del problema giapponese. Partiremo dal debito pubblico e dal fallimento dell’Abenomics, per comprendere come una politica monetaria espansiva possa trasformarsi in dipendenza sistemica. Affronteremo il crollo del carry trade come minaccia strutturale alla liquidità globale. Ci addentreremo nella crisi demografica, in una società che invecchia senza generare ricambio. Analizzeremo la sfiducia crescente dei consumatori, che blocca il mercato interno e spegne ogni dinamismo. E infine, racconteremo il paradosso del debito perpetuo, quell’illusione per cui un’economia può finanziarsi all’infinito senza conseguenze, salvo poi scoprire che la realtà chiede sempre il conto.
Il Giappone, nella sua silenziosa agonia, ci mostra il futuro che ci attende se non cambiamo paradigma. Non un collasso spettacolare, ma una ritrazione sistemica, lenta, dolorosa e inesorabile. Una desertificazione del senso, della vitalità economica, della capacità di rigenerarsi. Per questo è urgente guardare oltre le apparenze. Perché da Oriente non arriva solo un monito, ma una cartina tornasole. E se sapremo leggerla in tempo, potremo forse evitare che la prossima crisi globale inizi nel punto più silenzioso della mappa.