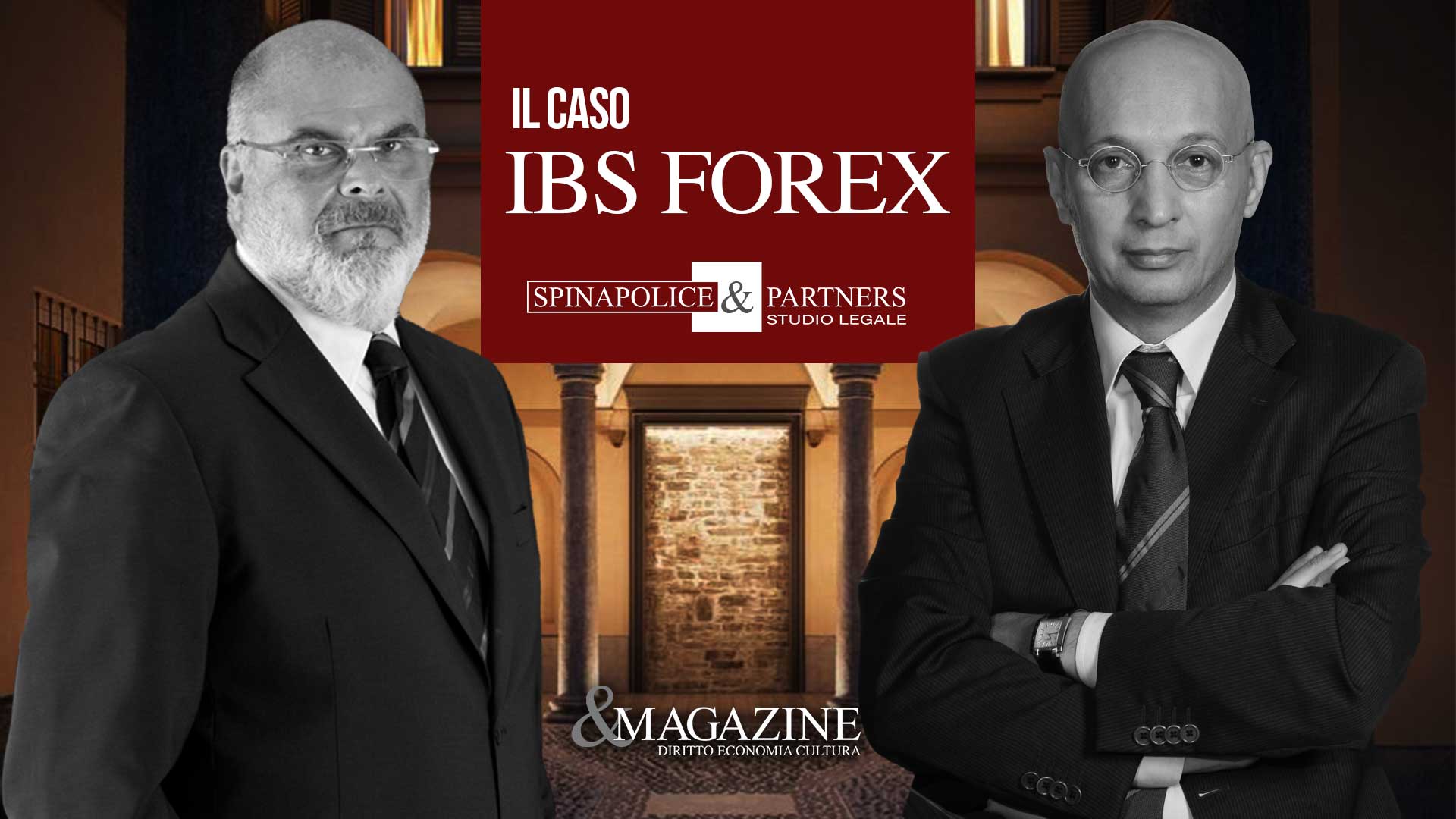Il caso Lehman Brothers rappresenta una delle pietre miliari più tragiche ma anche più istruttive nella storia della finanza contemporanea. È un racconto che intreccia ambizione, ingegneria finanziaria spinta all’estremo, illusioni collettive e una fragilità sistemica che ha scosso le fondamenta dell’economia globale. Tutto inizia ben prima del 2008, affondando le radici in un’America ottocentesca in piena espansione. I fratelli Lehman, immigrati tedeschi, iniziarono commerciando cotone nel sud degli Stati Uniti, costruendo lentamente una reputazione e accumulando capitale che sarebbe servito per l’evoluzione successiva della loro attività. Col passare dei decenni, quella bottega si trasformò in un gigante di Wall Street, divenendo un attore chiave nei mercati obbligazionari, nelle operazioni di mergers & acquisitions, nella strutturazione di prodotti finanziari innovativi e nel finanziamento di imprese che avrebbero poi guidato interi settori tecnologici e industriali.
Nel XXI secolo Lehman Brothers era ormai la quarta banca d’affari degli Stati Uniti, un simbolo della globalizzazione finanziaria, con operazioni che spaziavano dall’Asia all’Europa, fino alle start-up della Silicon Valley. Il suo modello si basava su una profonda integrazione nei mercati internazionali e su una fiducia incrollabile nelle dinamiche espansive dell’economia, supportata da una finanza sempre più complessa. Si trattava di un mondo dove le agenzie di rating assegnavano voti eccellenti a strumenti finanziari la cui rischiosità reale era molto più elevata di quanto apparisse. Dove i regolatori, spesso, erano un passo indietro rispetto all’innovazione dei banchieri. E dove gli incentivi, spinti dai bonus multimilionari dei manager, premiavano la crescita aggressiva più della prudenza.
All’inizio degli anni 2000 questo ambiente trovò un potente alleato: la politica monetaria estremamente accomodante della Federal Reserve, che manteneva bassi i tassi d’interesse per sostenere i consumi dopo la bolla di internet e l’11 settembre. Il denaro a buon mercato fece decollare il mercato immobiliare americano, alimentando un boom edilizio e spingendo le famiglie, anche quelle meno solvibili, a contrarre mutui. Da qui nacque la grande stagione dei mutui subprime, prestiti ipotecari concessi a clienti con basso merito creditizio, la cui sostenibilità era legata alla continua crescita dei prezzi delle case. In pratica, finché gli immobili salivano di valore, anche un debitore in difficoltà poteva vendere o rifinanziare, consentendo alle banche di recuperare quanto prestato.
Lehman Brothers, come molti altri colossi di Wall Street, vide in questi mutui un’occasione straordinaria. Non si limitava a concederli, ma li cartolarizzava: li trasformava in titoli derivati complessi, come i famosi CDO (Collateralized Debt Obligations), che venivano venduti agli investitori di tutto il mondo. Il guadagno era doppio: la banca incassava commissioni sulle emissioni e liberava spazio in bilancio per concedere nuovi prestiti, alimentando un ciclo apparentemente virtuoso. In più, grazie a modelli di rischio sofisticati e alla generosità delle agenzie di rating, quei pacchetti di mutui ricevevano spesso valutazioni di sicurezza altissime, inducendo fondi pensione, assicurazioni e investitori istituzionali a comprarli senza troppe verifiche.
Ma questa architettura finanziaria era costruita su fondamenta fragili. Quando, nel 2006-2007, la Federal Reserve iniziò a rialzare i tassi per contenere l’inflazione, il costo dei mutui a tasso variabile salì bruscamente. Milioni di famiglie americane si ritrovarono in difficoltà a pagare le rate. Contemporaneamente, il mercato immobiliare si saturò: i prezzi delle case smisero di salire e cominciarono a scendere. Questo doppio colpo fece esplodere i default sui mutui subprime, generando perdite colossali proprio su quei titoli cartolarizzati che banche e investitori avevano accumulato con troppa leggerezza.
Per Lehman Brothers fu l’inizio della fine. La banca aveva enormi esposizioni in strumenti legati ai mutui subprime e ai derivati connessi. Man mano che i valori di questi asset crollavano, il suo bilancio diventava sempre più vulnerabile. La fiducia del mercato iniziò a vacillare. Altri istituti smisero di concedere finanziamenti a breve termine a Lehman, timorosi di non essere ripagati. Si creò così una crisi di liquidità, che in un sistema bancario iper-leveraged è letale. Nell’estate del 2008 i vertici di Lehman tentarono disperatamente di trovare un compratore o un partner disposto a rilevare almeno una parte delle attività in sofferenza. Si parlarono di trattative con Barclays e Bank of America, ma nessuna andò in porto: l’incertezza sul valore reale degli asset scoraggiava chiunque.
Il governo americano, dopo aver salvato pochi mesi prima Bear Stearns e dopo aver nazionalizzato Fannie Mae e Freddie Mac, decise di non intervenire più. Fu una scelta in parte strategica, per ristabilire il principio del moral hazard, e far capire ai mercati che le banche dovevano assumersi la responsabilità delle loro scelte. Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers dichiarò bancarotta, dando vita al più grande default nella storia americana, per un buco stimato in oltre 600 miliardi di dollari.
Il terremoto fu immediato e globale. Se una banca delle dimensioni e della storia di Lehman poteva fallire, allora nessuno era davvero al sicuro. Il mercato interbancario si paralizzò: le banche smisero di prestarsi denaro tra loro per timore che anche il partner più solido potesse diventare insolvente dall’oggi al domani. Le imprese si ritrovarono senza credito, la produzione rallentò, la disoccupazione cominciò a salire. Le borse mondiali precipitarono in una spirale di vendite, mentre i risparmiatori cercavano di proteggere quanto potevano. L’ondata di sfiducia si propagò all’Europa, mettendo in difficoltà istituti tedeschi, britannici e del nord Europa che avevano nei loro portafogli enormi quantità di titoli tossici legati ai mutui americani.
A quel punto, i governi e le banche centrali furono costretti a intervenire con misure senza precedenti. La Federal Reserve, la BCE e le altre banche centrali tagliarono i tassi di interesse fino quasi a zero e iniettarono migliaia di miliardi di dollari e euro nei circuiti finanziari per scongelare il credito. I governi lanciarono colossali pacchetti di stimolo fiscale, come il TARP negli Stati Uniti, e vararono piani di salvataggio per le banche in difficoltà, talvolta costringendole a fusioni o nazionalizzazioni parziali. Queste mosse servirono a evitare il collasso completo del sistema, ma il prezzo fu altissimo in termini di debito pubblico e di crescente sfiducia nei confronti della finanza.
Il fallimento di Lehman Brothers segnò quindi un punto di svolta nella regolamentazione del settore finanziario. Emerse con chiarezza che il sistema aveva bisogno di regole più severe per evitare l’eccesso di leva finanziaria, la creazione incontrollata di prodotti opachi e la dipendenza cieca dai rating. Negli Stati Uniti fu approvato il Dodd-Frank Act, che introdusse stress test obbligatori, requisiti patrimoniali più robusti e maggiore trasparenza sui derivati. A livello internazionale si consolidarono gli accordi di Basilea III, che puntavano a rafforzare i capitali delle banche e a garantire una gestione più prudente dei rischi. Si sviluppò anche una nuova cultura della vigilanza macroprudenziale, con organismi incaricati di identificare e arginare i rischi sistemici prima che potessero sfociare in una crisi.
Tuttavia, l’eredità di Lehman Brothers ci ricorda che il sistema finanziario globale rimane intrinsecamente fragile. A distanza di più di quindici anni, persistono elementi di vulnerabilità: dall’eccessivo indebitamento di alcuni Stati, alle bolle speculative alimentate da anni di politiche monetarie ultra-espansive, fino alla crescita di settori ombra come gli hedge fund e il private equity, meno soggetti a supervisione. La più grande lezione lasciata da quella crisi è che, in un mondo iper-connesso e complesso, la vigilanza non può mai abbassarsi, e la regolamentazione deve continuare a evolvere per stare al passo con un’innovazione finanziaria che non si ferma mai.