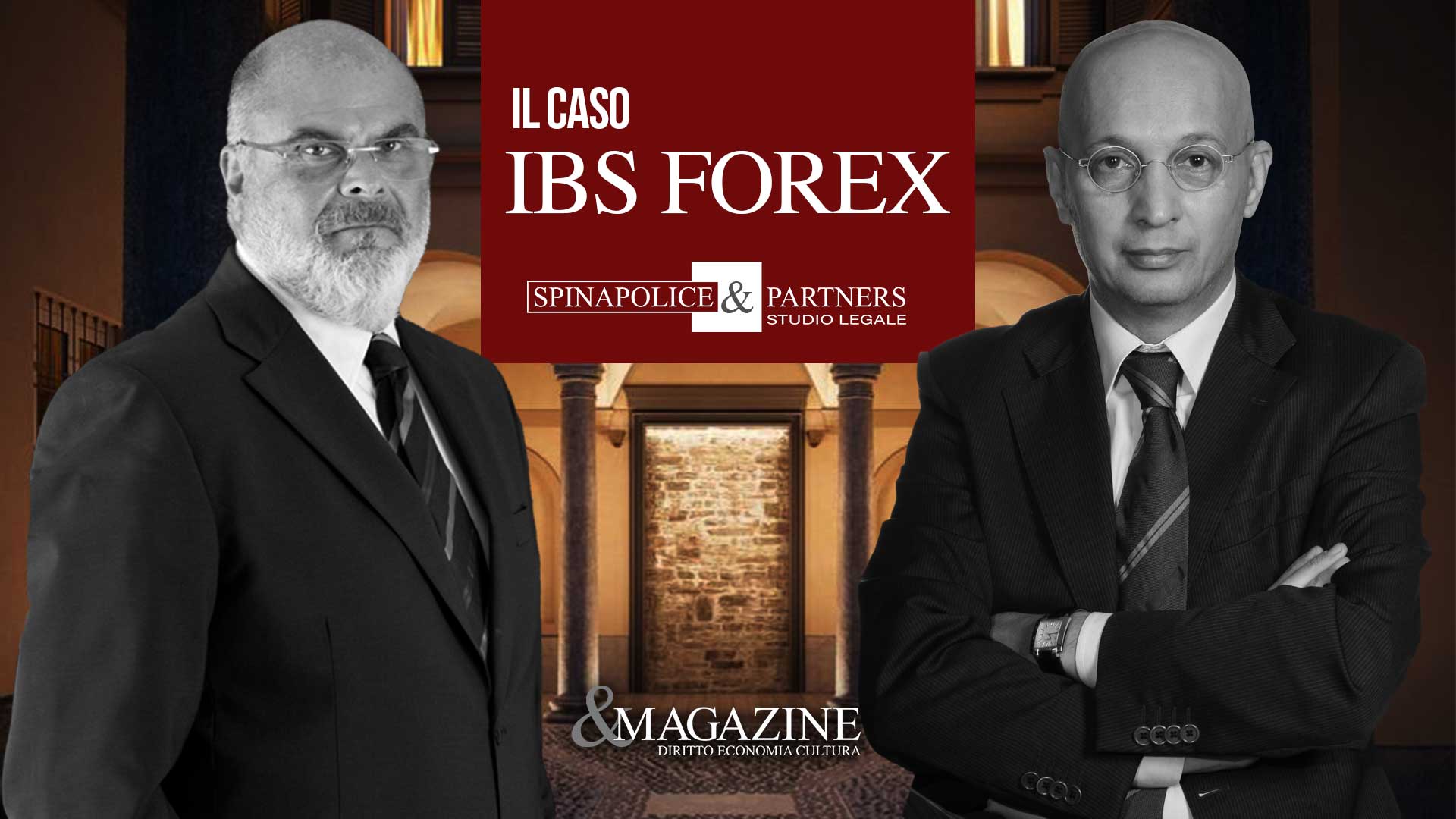Negli ultimi vent’anni il profilo del consumatore finanziario è mutato in modo radicale. Non si tratta solo di un cambiamento demografico o generazionale, ma di una trasformazione profonda nel comportamento, nelle aspettative e nel rapporto col rischio. Se un tempo il risparmiatore medio era prudente, legato a prodotti semplici e con un forte legame fiduciario con la propria banca di riferimento, oggi ci troviamo di fronte a un utente iper-connesso, apparentemente più informato ma spesso più esposto e vulnerabile.
La digitalizzazione dei mercati, l’accesso immediato alle piattaforme online, la disintermediazione dei tradizionali canali bancari hanno creato l’illusione di una finanza democratica, alla portata di tutti. Ma in realtà hanno spesso abbassato le difese. Molti consumatori si sentono in grado di gestire strumenti complessi, anche quando manca una reale educazione finanziaria. Non è raro vedere soggetti che investono in criptovalute, derivati, trading ad alta frequenza senza comprenderne la natura, mossi più dall'emotività che da un’analisi razionale.
Contemporaneamente, sono aumentate in modo esponenziale le truffe finanziarie, camuffate da opportunità di guadagno veloce o da finti investimenti garantiti. Gli schemi Ponzi, le società fittizie, i consulenti improvvisati o le piattaforme estere prive di autorizzazioni si sono moltiplicati. Il problema non è solo la presenza di malintenzionati – che ci sono sempre stati – ma l’abbassamento della soglia critica dei risparmiatori. È cresciuta una certa leggerezza, talvolta alimentata da una narrazione distorta del successo, dove l'investimento veloce e redditizio viene esaltato come sinonimo di intelligenza o furbizia.
A ciò si aggiunge una progressiva erosione della fiducia nelle istituzioni tradizionali, a partire dalle banche. Le crisi bancarie, i salvataggi statali, i bond subordinati venduti come sicuri, hanno minato la credibilità del sistema e spinto molti utenti a cercare soluzioni alternative, spesso non regolamentate. Paradossalmente, il venir meno di un interlocutore stabile ha fatto sì che il risparmiatore si affidasse a chiunque gli offrisse una promessa credibile, anche senza garanzie.
La comunicazione finanziaria si è nel frattempo adattata a logiche più commerciali che consulenziali, e il confine tra informazione e pubblicità si è fatto sottile. Questo ha contribuito a creare aspettative irrealistiche, alimentate da influencer, video su YouTube, gruppi Telegram che promettono ricchezza senza fatica.
Siamo entrati in un’epoca in cui il consumatore finanziario è tecnicamente più evoluto, ma eticamente e psicologicamente più fragile. La velocità, l’apparente controllo, la pressione sociale e la mancanza di alfabetizzazione economica hanno aperto un varco a truffatori vecchi e nuovi. Difendersi oggi richiede più che mai consapevolezza, competenza e senso critico, e forse anche il recupero di una certa umiltà: quella di sapere che non tutto ciò che brilla è oro, soprattutto in finanza.