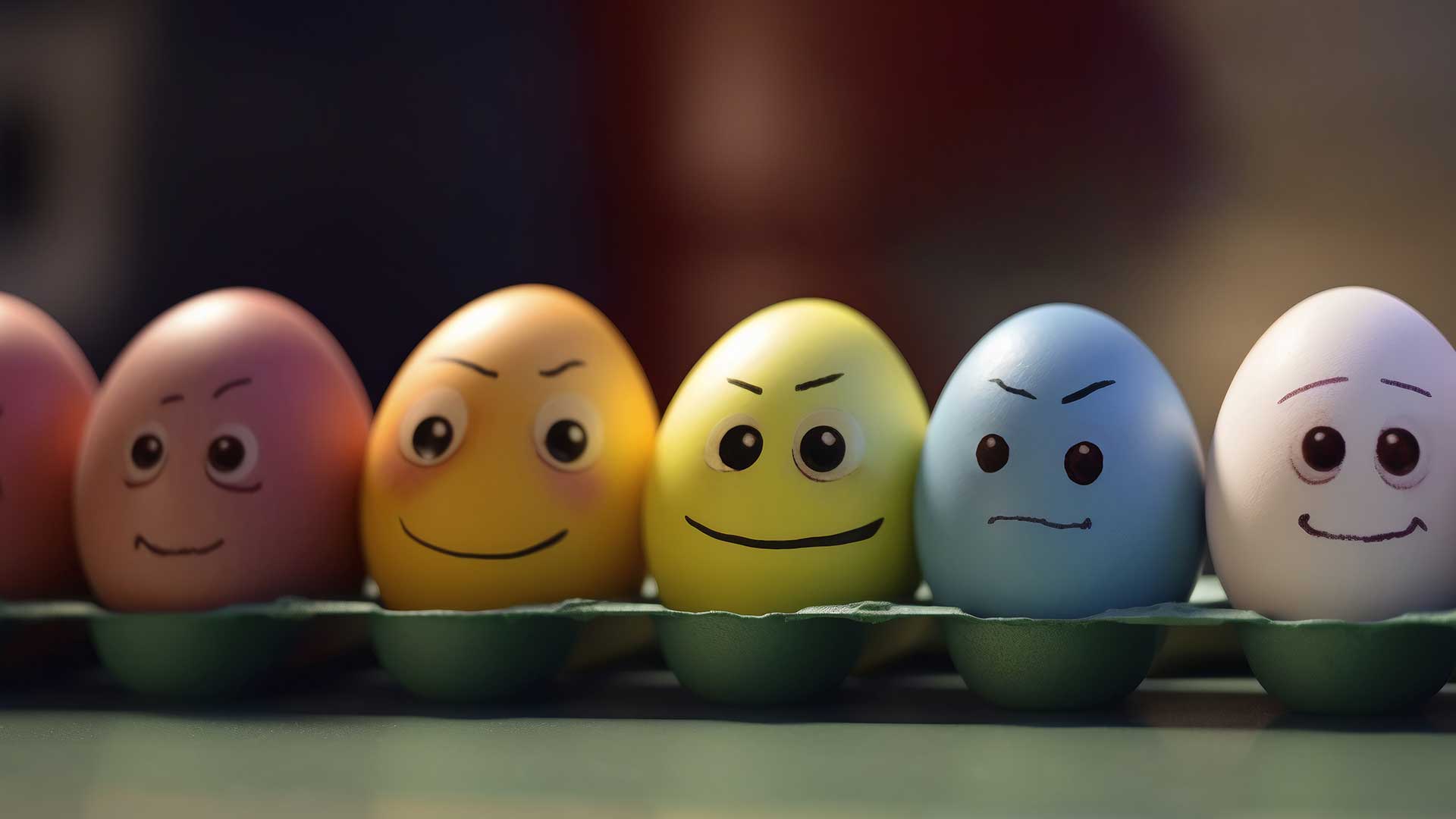Il futuro non è più atteso, ma venduto. Non si profetizza, si preconfeziona. Non si costruisce, si annuncia. La narrazione futuristica è divenuta uno strumento retorico di massa, un dispositivo semiotico che molte aziende impiegano come una leva di posizionamento, una valuta simbolica attraverso cui promettere valore senza consegnarlo. La proiezione nel futuro si è smarcata dalla fatica del presente: non serve più dimostrare, basta immaginare. Questa tendenza, sempre più evidente nella comunicazione strategica di grandi imprese, banche e persino istituzioni pubbliche, ha generato un fenomeno che potremmo definire futurewashing, un’estensione del più noto greenwashing, ma ancora più pervasiva e sottile.
Le parole chiave si moltiplicano: intelligenza artificiale, transizione ecologica, inclusività, digitalizzazione, blockchain, autenticazione biometrica, sostenibilità sociale. Il futuro è ovunque, ma raramente è adesso. L’impresa contemporanea parla di ciò che sarà per evitare di mostrare ciò che è. Il marketing ha capito che il tempo è diventato emozionale, e che le promesse, se pronunciate con il tono giusto, hanno più peso dei risultati. Nasce così un’inflazione dell’immaginario, una dilatazione incontrollata del possibile che finisce per svalutare il reale. Ogni azienda è una profetessa. Ogni brand è una narrazione. Ogni campagna pubblicitaria è una visione.
Ma cosa accade quando il linguaggio dell’avvenire si fa struttura permanente di marketing? Quando il racconto del domani si sostituisce alla concretezza dell’oggi? La risposta risiede nella mutazione simbolica che la comunicazione ha subito nel passaggio da bene a promessa, da prodotto a percezione, da realtà a risonanza semiotica. In tale contesto, il branding non è più il vestito del prodotto, ma il suo orizzonte mitologico. Si parla della banca che nel 2030 offrirà consulenze tramite avatar sensibili, dell’azienda agricola che nel 2045 coltiverà pomodori su Marte, del brand di moda che nel 2100 userà solo tessuti computazionali. Nessuno chiede verifiche. Nessuno pretende piani. Basta che sia emozionante. Basta che sia visionario.
Il futurewashing funziona perché disinnesca la verifica. Mentre il greenwashing si espone, prima o poi, alla confutazione empirica (un prodotto o è ecosostenibile o non lo è), il futurewashing si fonda su enunciazioni non falsificabili. Il futuro non è ancora accaduto, dunque non può essere smentito. Ecco allora che si creano campagne dove il brand diventa ambasciatore di un mondo che ancora non esiste, ma che già reclama appartenenza, fiducia, adesione valoriale. In questa logica, la promessa del futuro diventa un dispositivo identitario: tu non acquisti un prodotto, tu aderisci a una profezia.
In tutto ciò, l’etica si assottiglia fino a svanire. L’accountability perde consistenza, perché non c’è più un rapporto tra dichiarazioni e performance, bensì tra dichiarazioni e narrazioni. Il valore di un’impresa si misura nella capacità di ispirare, non più in quella di realizzare. Il brand che promette un futuro etico non ha più bisogno di agire eticamente oggi: gli basta simulare l’intenzione. Eppure, proprio questa simulazione diventa reale nei suoi effetti, perché orienta i capitali, le fiducie, le preferenze, le adesioni simboliche. In altre parole, il futuro dichiarato sostituisce il presente verificabile.
Nel tempo breve e nervoso dell’economia digitale, il futuro ha smesso di essere una progettualità per diventare una moneta emozionale. Le aziende vendono visioni come prima vendevano vantaggi competitivi. Parlano di sostenibilità nel 2050 per non rendicontare le emissioni del 2025. Parlano di metaversi per evitare di riformare le filiere fisiche. Parlano di intelligenza artificiale per distogliere dalla mancanza di intelligenza organizzativa. È un meccanismo di distrazione strategica, ma anche una forma di colonizzazione del senso. Se il marketing controlla l’immaginazione collettiva del futuro, controlla le aspettative, le paure, i desideri.
Mai come adesso si apre uno spazio critico importante: quello dell’etica dell’immaginazione. Le imprese hanno oggi una responsabilità che va oltre la conformità normativa: quella di custodire il potere simbolico delle loro parole. Proiettare visioni del futuro è un atto performativo, perché influisce sulla realtà anticipandola. Le metafore usate, i mondi evocati, gli scenari delineati modellano il campo del possibile. Dire “un giorno saremo sostenibili” genera meno cambiamento che dire “oggi siamo responsabili”. Ma la prima è più comoda, più rassicurante, più redditizia. Non richiede scelte, ma solo consenso.
La semiotica del futuro è diventata una scienza pubblicitaria. I brand costruiscono linee temporali alternative dove sono sempre protagonisti del cambiamento, eroi del progresso, pionieri di nuovi mondi. È una forma di narrazione egemonica che cancella le contraddizioni presenti e depotenzia il conflitto. Non si discute più se un’impresa fa del bene, ma se comunica abbastanza purpose. Si premia il tono, non la coerenza. Si applaude l’ambizione, non la responsabilità. Il tempo stesso si piega alla logica del brand: è domani il nuovo campo di battaglia per conquistare clienti, mercati, reputazioni.
Il paradosso è che questo uso massivo del futuro rischia di svuotare il futuro stesso. L’abuso di linguaggi proiettivi genera assuefazione narrativa, rende ogni promessa uguale a tutte le altre, ogni innovazione indistinguibile, ogni visione ripetitiva. Quando tutto è futuro, niente è veramente nuovo. L’immaginazione si affolla di slogan, si ingolfa di concept, si spegne sotto il peso delle sue stesse metafore. Il rischio è che le imprese, nell’intento di distinguersi, finiscano per somigliarsi tutte. Che il futuro promesso diventi un esercizio di stile, piuttosto che un impegno concreto.
Eppure, esiste un’altra via. Un modo per tornare a un marketing del reale, che non rinuncia alla potenza visionaria, ma la ancora alla responsabilità presente. Un branding che non separa ciò che sarà da ciò che già si fa. Un immaginario che non serve a sedurre, ma a rivelare. In questo senso, il compito più alto del marketing contemporaneo non è costruire promesse, ma generare fiducia attraverso la trasparenza delle azioni. Non è raccontare futuri ipotetici, ma abitare con coraggio l’ambiguità del presente.
Contro il futurewashing serve una etica narrativa nuova, capace di tenere insieme sogno e concretezza, ispirazione e verifica. Un’etica che riconosca la forza performativa del linguaggio e ne usi la potenza per trasformare la realtà, non per sfuggirla. Perché il futuro, se è solo marketing, diventa un alibi. Ma se è visione responsabile, può ancora essere una promessa autentica.