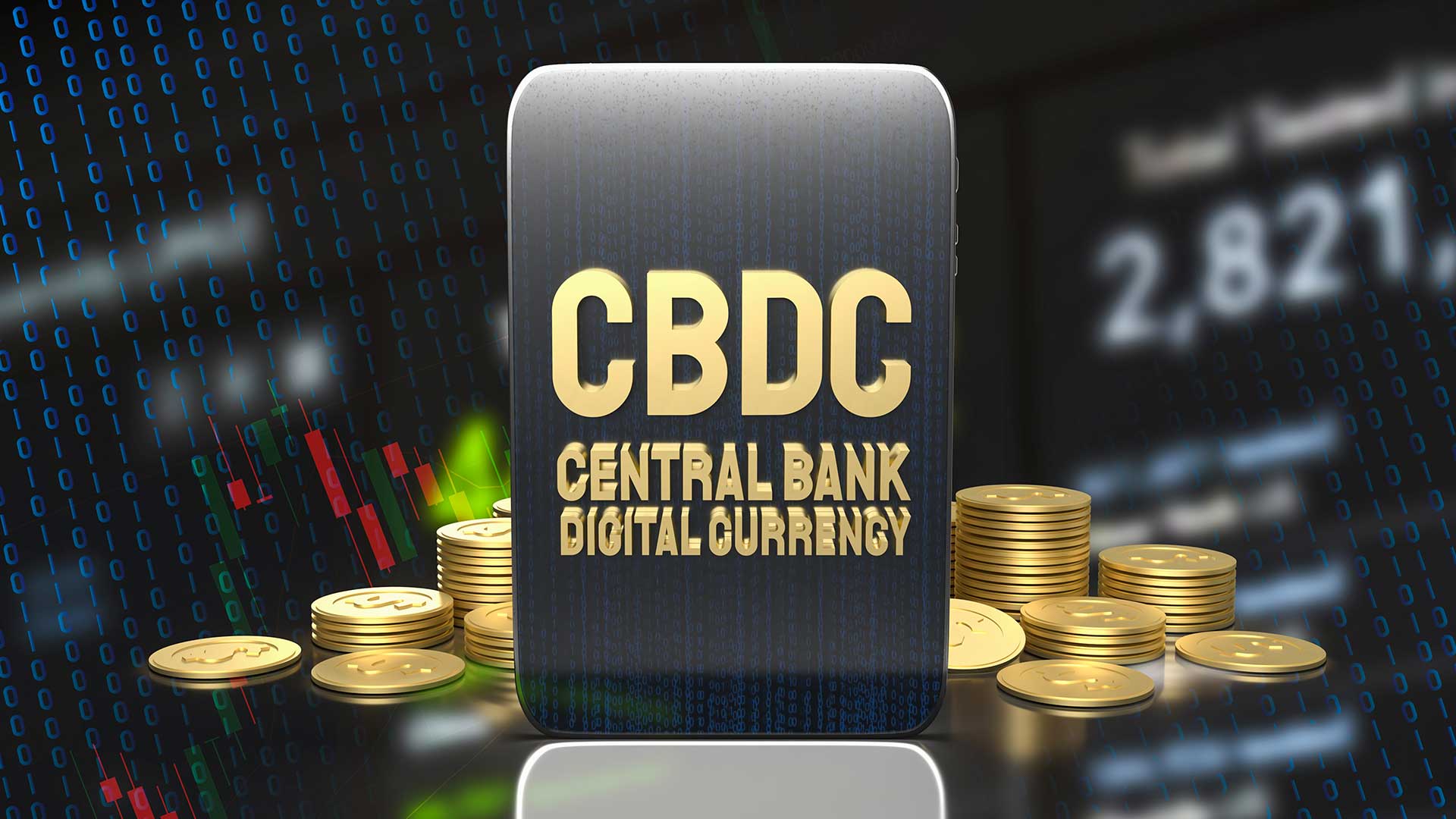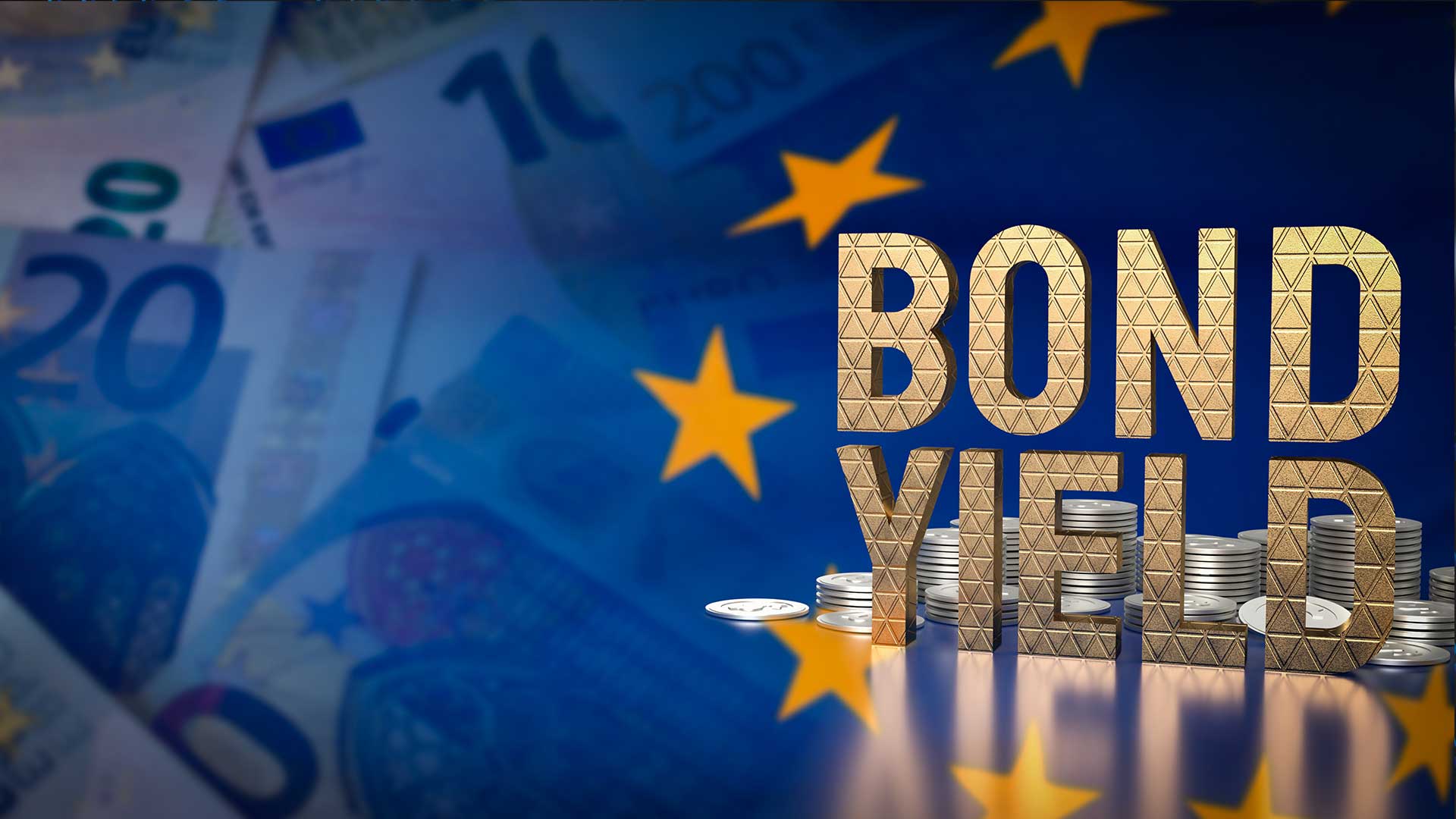Il Giappone è il grande malato elegante dell’economia mondiale. Silenzioso, ordinato, efficiente, ma al tempo stesso fragile, invecchiato, saturo. Da decenni, la sua stagnazione economica è un monito che il mondo osserva con rispetto misto a inquietudine. Eppure, oggi qualcosa sta cambiando. Non è più solo una questione giapponese. Le sue debolezze strutturali, la sua politica monetaria ultra-espansiva, il suo debito pubblico fuori scala, rischiano di trasformarsi nel primo anello che si spezza in una catena finanziaria globale ormai tesa al limite. Il Giappone, che per anni ha galleggiato con tassi di interesse a zero e una fiducia zen nelle proprie istituzioni, potrebbe ora diventare la scintilla che accende un incendio nei mercati di tutto il mondo.
Per capire perché, bisogna tornare indietro. La grande crisi giapponese inizia nei primi anni '90, quando esplode una colossale bolla immobiliare. Da allora, il Paese del Sol Levante entra in un’epoca che verrà definita “il decennio perduto”, ma che in realtà diventerà un’era lunga oltre trent’anni di crescita anemica, deflazione, e interventismo statale cronico. Le autorità rispondono con politiche di stimolo massicce, ma inefficaci. Il risultato è un debito pubblico che sale vertiginosamente, superando il 200% del PIL e diventando il più alto al mondo tra le economie avanzate. Ma a differenza di altri Paesi, il Giappone non cade. Non esplode. Regge. Grazie a un elemento chiave: il controllo interno sul debito.
Circa il 90% dei titoli di stato giapponesi sono detenuti da soggetti nazionali: banche, assicurazioni, fondi pensione, e soprattutto la Bank of Japan, che per anni ha monetizzato il debito acquistando titoli sul mercato secondario in quantità quasi illimitata. Questa caratteristica ha reso il debito giapponese apparentemente sostenibile, nonostante l’assenza di crescita e la scarsità di entrate fiscali. L’esperimento sembrava funzionare. Ma era un equilibrio precario. Una sospensione dell’economia reale, fondata su fiducia, omogeneità sociale, e una popolazione disposta a risparmiare più che a consumare.
Negli anni successivi, il governo prova un’ultima scommessa ambiziosa: la “Abenomics”, la strategia lanciata dal premier Shinzo Abe nel 2012, che unisce espansione monetaria, stimolo fiscale e riforme strutturali. Ma solo la prima “freccia” viene realmente scoccata. I tassi d’interesse crollano sotto lo zero, la banca centrale compra titoli a man bassa, ma la crescita non arriva. Le riforme si impantanano nella burocrazia e nell’opposizione sociale. I consumi restano deboli, l’invecchiamento della popolazione erode la forza lavoro e aumenta i costi previdenziali. Il mercato interno si restringe, la domanda è fiacca, l’export giapponese perde competitività di fronte all’avanzata della Cina e di altri paesi emergenti. E, intanto, lo yen si svaluta lentamente, spingendo molti investitori stranieri ad approfittare del differenziale dei tassi attraverso una strategia che diventerà cruciale: il carry trade.
Il carry trade è una forma sofisticata di arbitraggio finanziario. In sostanza, investitori internazionali prendono in prestito yen a tassi bassissimi in Giappone, li convertono in dollari, euro o altre valute, e li investono in titoli di stato, obbligazioni o azioni in Paesi dove i rendimenti sono più alti. Il differenziale tra il costo del prestito e il rendimento dell’investimento è il profitto. In teoria è una strategia win-win. Ma nella pratica diventa una dipendenza globale. Anno dopo anno, miliardi e miliardi di yen lasciano il Giappone per finanziare il debito di altri Paesi, alimentare le borse occidentali, sostenere asset di ogni tipo. Il Giappone, paradossalmente, diventa la banca silenziosa del mondo, senza volerlo.
Questo meccanismo ha tenuto in piedi un pezzo importante dell’architettura finanziaria mondiale. Finché i tassi giapponesi restano a zero, tutto funziona. Ma cosa succede se cambiano le condizioni? Ecco la crepa che oggi spaventa gli analisti. Nel 2022, con la guerra in Ucraina, iniziano a salire i prezzi delle materie prime. L’inflazione, da anni assente in Giappone, torna a farsi sentire. Nel 2023, il governo è costretto a interrompere molti sussidi. E nel 2024, dopo anni di tassi negativi, la Bank of Japan alza i tassi di interesse per frenare l’aumento dei prezzi.
È il momento critico. Per la prima volta in oltre un decennio, il costo del denaro in Giappone risale. Questo significa che finanziare nuovo debito diventa più oneroso anche per lo stesso Stato giapponese, che già spende una fetta gigantesca del proprio bilancio per pagare gli interessi. Ma soprattutto significa che finisce l’epoca del carry trade a basso costo. Gli investitori esteri non trovano più conveniente indebitarsi in yen. I flussi si interrompono. E alcuni iniziano persino a vendere le posizioni accumulate negli anni.
A questo punto si crea un buco sistemico. I fondi che per anni avevano investito usando lo yen si ritrovano con titoli che perdono valore, proprio mentre devono affrontare tassi più alti e condizioni creditizie più restrittive. Gli effetti non si fermano in Giappone. Le obbligazioni di tutto il mondo iniziano a perdere attrattività. Gli Stati, per trovare nuovi compratori, devono alzare i tassi, peggiorando a loro volta i propri conti pubblici. Il debito globale diventa più costoso, più fragile, più rischioso.
In questo scenario, il Giappone non è solo una vittima delle circostanze. È un agente attivo di destabilizzazione involontaria. La sua transizione monetaria da ultra-espansiva a restrittiva incide direttamente sui meccanismi attraverso cui il mondo si è finanziato nell’ultimo decennio. E c’è di più: il Giappone è anche il primo detentore straniero del debito pubblico americano. Se decidesse o fosse costretto a liquidare parte di questi asset per far fronte ai propri squilibri interni, potrebbe innescare un crollo dei Treasury USA, con conseguenze devastanti per l’intero sistema finanziario globale.
In parallelo, il Paese è schiacciato da problemi demografici senza precedenti. Oltre il 29% della popolazione ha più di 65 anni. La forza lavoro diminuisce, la produttività arranca, i giovani sono pochi, e spesso scoraggiati. Il mercato interno è asfittico, e la fiducia nel futuro ai minimi storici. I consumi calano, i risparmi aumentano, ma questi yen accumulati sono vulnerabili all’inflazione. Se la fiducia nello yen cala, può generarsi una fuga verso asset esteri, aggravando la debolezza della moneta e costringendo la banca centrale a nuovi rialzi dei tassi, in un circolo vizioso difficile da spezzare.
In questo contesto, ogni decisione politica è un gioco d’equilibrio. Tagliare la spesa pubblica significa abbandonare a sé stesse milioni di famiglie e imprese. Aumentare le tasse, come nel 2019 con il raddoppio dell’IVA, può distruggere i consumi. Stampare moneta, come fatto finora, non ha più gli effetti desiderati, anzi, rischia di innescare perdite strutturali nei fondi pensione e negli investitori istituzionali. Il Giappone è in trappola. Una trappola demografica, fiscale, monetaria e culturale.
Eppure, il mondo non può distogliere lo sguardo. Perché ciò che accade a Tokyo, a Osaka, a Kyoto, oggi ha implicazioni che arrivano fino a Francoforte, New York e Pechino. Il domino finanziario è pronto. E il primo tassello è lì, immobile, che oscilla.