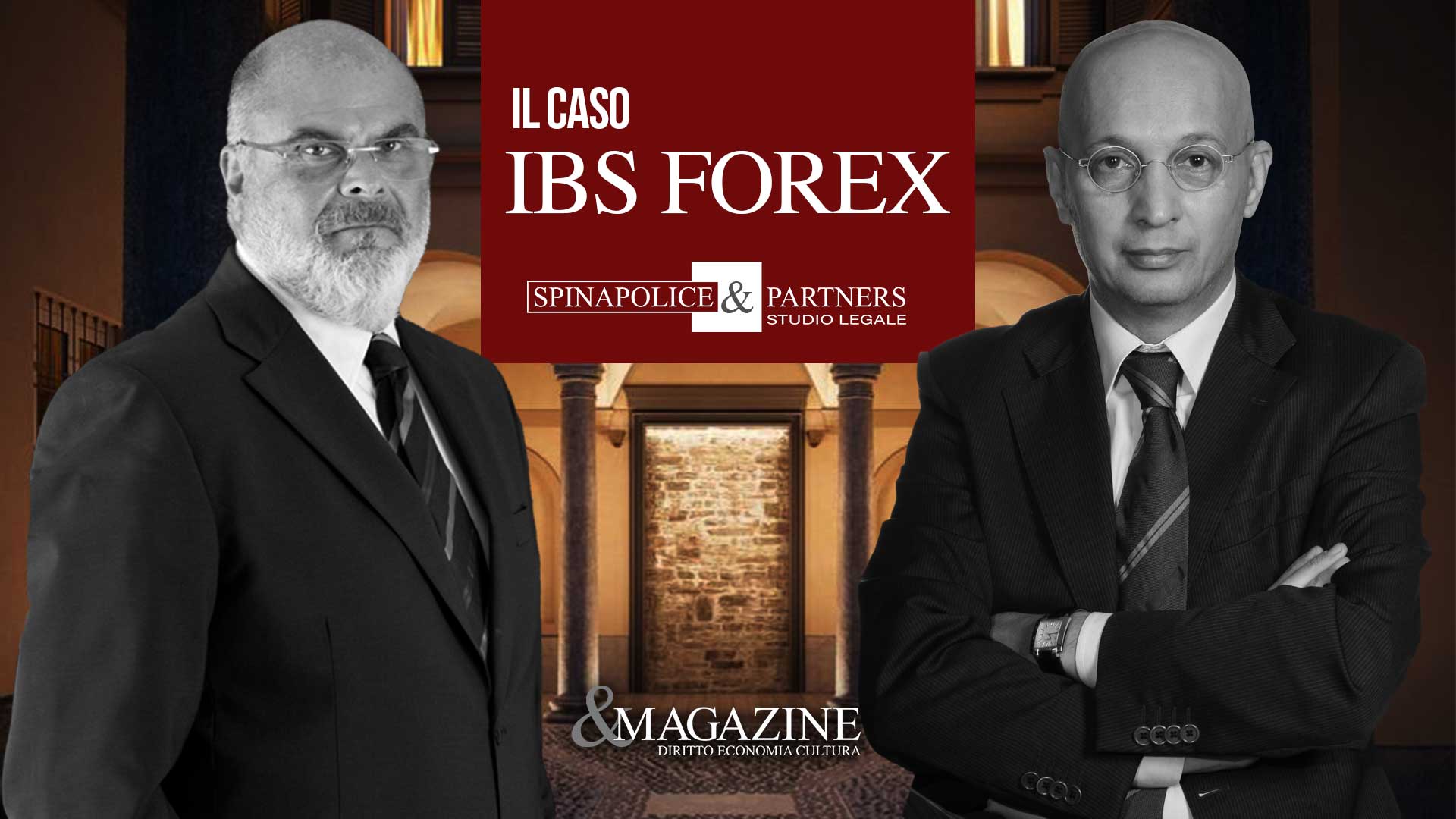Il boom dei mutui subprime e la conseguente esposizione di Lehman Brothers costituiscono una delle storie più emblematiche della finanza moderna, un racconto intricato in cui avidità, illusione, deregulation e una fiducia cieca nelle formule matematiche si sono combinati per generare una delle peggiori crisi finanziarie della storia recente. All’inizio degli anni 2000, gli Stati Uniti attraversavano un periodo di apparente prosperità. I tassi di interesse mantenuti bassi dalla Federal Reserve, dopo lo scoppio della bolla dot-com e gli attacchi dell’11 settembre, alimentavano la domanda di case. Il mercato immobiliare diventò così il motore della crescita economica, sostenuto da una politica monetaria espansiva che incoraggiava famiglie e investitori a contrarre prestiti.
In questo scenario roseo si inserì la spinta aggressiva del settore bancario, deciso a espandere la platea dei mutuatari ben oltre i tradizionali clienti solvibili. Nacquero così i mutui subprime, ovvero finanziamenti ipotecari concessi a soggetti con scarso merito creditizio, persone che per la loro storia di pagamenti incerta o per un livello di reddito insufficiente sarebbero stati normalmente escluse dal credito. La logica che li sosteneva si fondava su due convinzioni rivelatesi poi illusorie: primo, che il valore delle case fosse destinato a crescere indefinitamente, garantendo in ogni caso la copertura del prestito; secondo, che il rischio potesse essere “spalmato” e quindi ridotto attraverso la cartolarizzazione.
La cartolarizzazione era infatti il cuore pulsante di questo sistema. Le banche, dopo aver concesso i mutui, non li tenevano più a lungo nei propri bilanci, ma li impacchettavano in strumenti finanziari complessi chiamati CDO (Collateralized Debt Obligations), a loro volta suddivisi in tranche con differenti livelli di rischio e rendimento. Questi titoli venivano poi collocati sul mercato globale, finendo nei portafogli di fondi pensione, assicurazioni, piccole banche regionali e persino enti pubblici di mezzo mondo. La convinzione, sostenuta da sofisticati modelli matematici e dalle rassicuranti pagelle delle agenzie di rating, era che il rischio complessivo fosse basso, perché diversificato su migliaia di mutui sparsi su tutto il territorio americano.
Ma dietro questa architettura apparentemente solida si nascondeva una fragilità strutturale. I mutui subprime erano per definizione prestiti ad alto rischio, e la loro concentrazione in certi strumenti, combinata con pratiche di concessione sempre più disinvolte (basti pensare ai famigerati NINJA loans, acronimo di No Income, No Job, No Assets), fece sì che la qualità di questi asset fosse in molti casi prossima al disastro. I mutuatari, attratti da tassi iniziali bassissimi e convinti di poter rifinanziare il debito in futuro grazie alla continua salita dei prezzi immobiliari, si ritrovarono invece schiacciati non appena i tassi cominciarono a salire e i valori delle case a scendere.
Lehman Brothers fu uno dei principali protagonisti di questa corsa sfrenata. Fondata a metà Ottocento dai fratelli Lehman, immigrati tedeschi che iniziarono commerciando cotone, la banca era cresciuta fino a diventare una colonna di Wall Street, impegnata in operazioni di investment banking, fusioni e acquisizioni, emissioni obbligazionarie. Nei primi anni 2000, Lehman vide nel mercato immobiliare un’opportunità straordinaria di guadagno. Si lanciò a capofitto nell’acquisto di mortgage-backed securities (MBS) e nella creazione di propri CDO, accumulando nei bilanci quantità impressionanti di asset legati al real estate.
A guidare questa strategia c’era la convinzione, condivisa da gran parte del settore, che il rischio fosse gestibile e che i default su scala sistemica fossero improbabili. Il problema, tuttavia, era duplice: da un lato, Lehman si esponeva direttamente acquistando grandi portafogli di mutui e derivati immobiliari; dall’altro, moltiplicava l’esposizione finanziando e strutturando strumenti per i propri clienti, spesso garantendo la liquidità delle operazioni tramite linee di credito che la stessa banca forniva.
In questo contesto, i dirigenti di Lehman Brothers continuarono a premere sull’acceleratore, spinti da un sistema di incentivi che premiava i profitti trimestrali e ignorava i rischi di lungo periodo. I bonus milionari erano infatti legati ai ricavi immediati, mentre le perdite potenziali rimanevano sullo sfondo. Ciò creò un enorme conflitto di interessi, incoraggiando la banca a prendere decisioni sempre più azzardate pur di mantenere alta la redditività.
Non va dimenticato il ruolo cruciale delle agenzie di rating, che attribuivano a molti di questi CDO giudizi elevatissimi, spesso AAA, come se si trattasse di titoli di Stato americani. Questo permise di vendere tali prodotti a investitori istituzionali vincolati da regolamenti interni che consentivano di acquistare solo asset considerati estremamente sicuri. Il paradosso fu che strumenti composti in larga parte da mutui subprime finivano per avere un rating equivalente a quello del Tesoro USA.
Il castello di carte crollò quando il mercato immobiliare americano invertì la rotta. A partire dal 2006, i prezzi delle case iniziarono a diminuire, lasciando milioni di proprietari con mutui superiori al valore dell’immobile. I default sui pagamenti si moltiplicarono e, con essi, le perdite per chi deteneva MBS e CDO. I modelli matematici su cui si basavano le valutazioni di rischio si rivelarono del tutto inadeguati: avevano infatti sottostimato la possibilità che un calo simultaneo dei valori immobiliari in diverse regioni potesse mandare in crisi l’intero sistema.
Per Lehman Brothers, la tempesta fu fatale. La banca si trovò con un’enorme quantità di asset diventati improvvisamente illiquidi e svalutati. Tentò disperatamente di raccogliere capitali freschi e di vendere porzioni del proprio portafoglio, ma la sfiducia ormai diffusa nei confronti di tutti gli operatori esposti ai subprime rese impossibile trovare compratori a prezzi sostenibili. Nel settembre del 2008, dopo frenetici tentativi di salvataggio e trattative fallite con potenziali acquirenti come Barclays e Bank of America, Lehman Brothers dichiarò bancarotta. Fu il più grande fallimento nella storia americana, con un passivo di oltre 600 miliardi di dollari.
Il crack di Lehman ebbe effetti devastanti. Innescò una crisi di fiducia globale che congelò i mercati interbancari, portò al collasso altre istituzioni finanziarie e richiese interventi massicci da parte dei governi per stabilizzare il sistema. La lezione più amara fu che la ricerca incessante del profitto, sostenuta da una deregulation compiacente e da valutazioni del rischio distorte, aveva creato una bolla di proporzioni colossali, alimentata dalla convinzione che la finanza potesse trasformare l’azzardo in sicurezza.
Ancora oggi, a distanza di anni, il caso Lehman Brothers viene studiato nelle business school e nei corsi di economia come paradigma di quanto possano essere pericolosi gli eccessi di leva finanziaria, la mancanza di trasparenza e la sopravvalutazione della capacità dei modelli matematici di prevedere il comportamento dei mercati. Il boom dei mutui subprime e la successiva crisi hanno lasciato un’eredità duratura, spingendo le autorità a introdurre nuove regole, come i requisiti di capitale più stringenti e controlli più severi sulla valutazione del merito creditizio. Ma molti osservatori si chiedono se queste riforme siano davvero sufficienti a scongiurare in futuro crisi di simile portata.
Il fascino del rendimento elevato e l’illusione di poter cancellare il rischio tramite la finanziarizzazione continuano infatti a esercitare un’attrazione potente. Come in un eterno ritorno, i mercati sembrano periodicamente dimenticare le lezioni del passato. La storia di Lehman Brothers resta allora non solo un monito per i banchieri e i regolatori, ma anche per tutti noi: l’avidità, mascherata da ingegneria finanziaria, ha un costo altissimo quando perde il contatto con l’economia reale e con la prudenza che dovrebbe sempre guidare l’uso del denaro.