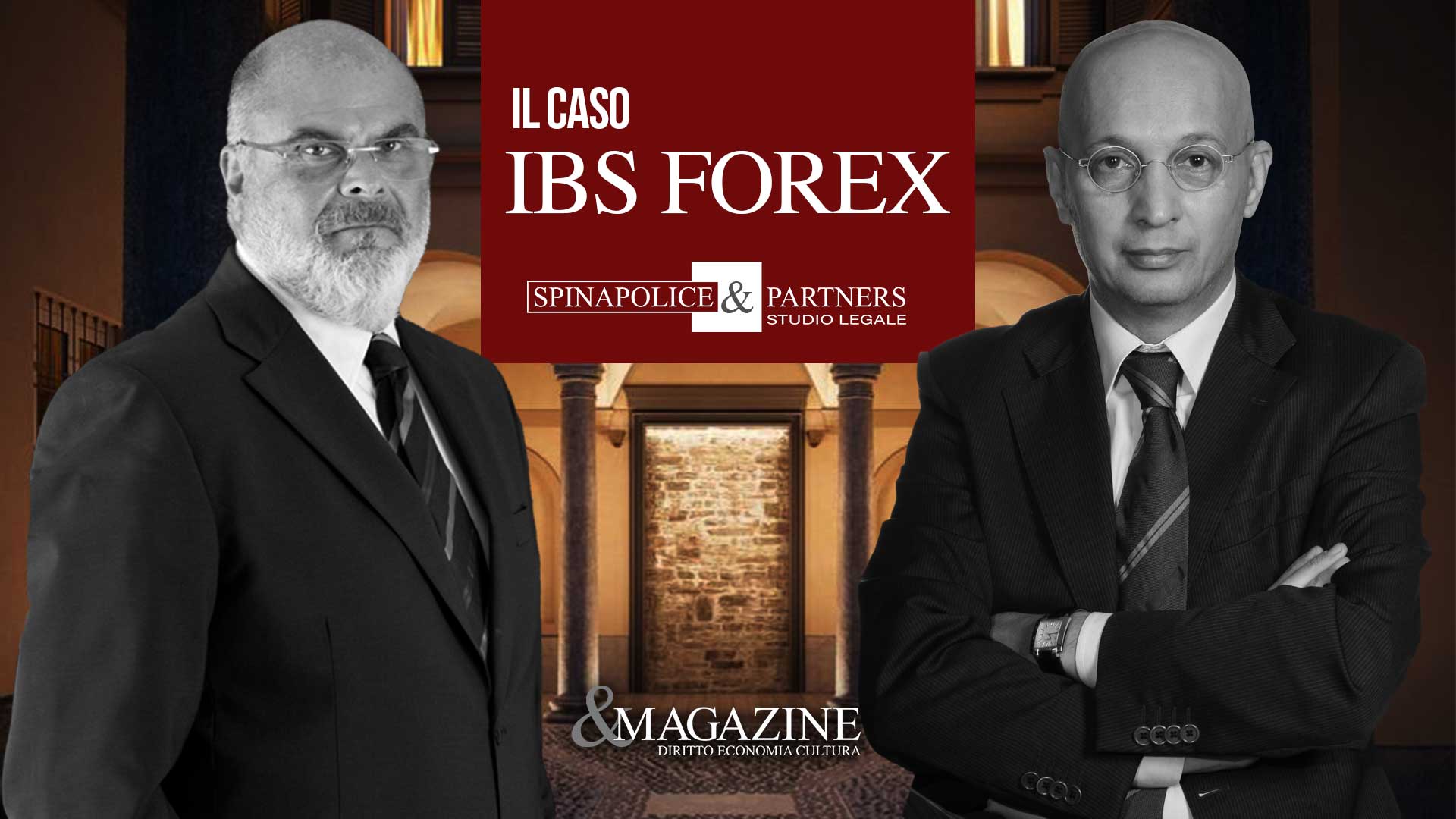Nel cuore degli anni Settanta, l’Italia visse un paradosso che oggi appare incredibile: le banche private emisero migliaia di pezzi di carta che, di fatto, sostituirono la moneta legale. Erano i cosiddetti miniassegni, e per circa tre anni diventarono denaro circolante in tutto il Paese, senza che lo Stato li avesse mai autorizzati. Erano illeciti, ma tutti li accettavano. Furono illegali, ma resero profitti enormi. E come oggi accade per molte criptovalute, divennero simbolo di deregolamentazione, speculazione e opportunismo finanziario.
Tutto cominciò con la crisi della moneta spicciola. Nel 1975, l’Italia soffriva di una grave inflazione, la Zecca dello Stato era sovraccarica di richieste di banconote, e la produzione di monete metalliche fu rallentata. Circolavano teorie sulle monete scomparse: c’erano i turisti che le portavano via, gli artigiani che le trasformavano in bottoni, gli orologiai giapponesi che ne facevano casse, e perfino la voce insistente di una speculazione organizzata.
In questo vuoto, emersero i miniassegni: pezzi di carta stampati dalle banche commerciali con importi ridicoli (50, 100, 150 lire), formalmente presentati come assegni circolari, ma in realtà usati e accettati come moneta. Ne furono emessi oltre 835 tipi diversi, da 33 istituti bancari, per un valore stimato di oltre 200 miliardi di lire. Nessuna autorizzazione statale, nessuna garanzia di convertibilità, nessuna copertura in moneta legale.
In pratica, le banche crearono moneta in barba all’art. 11 della Legge n. 262/1947 e all’art. 127 della Costituzione, che riservano esclusivamente allo Stato l’emissione monetaria. Il 25 marzo 1976, la Procura della Repubblica di Perugia intervenne: i miniassegni vennero definiti una violazione delle norme sull’emissione di valuta, e fu disposto il sequestro su tutto il territorio nazionale per le emissioni da 100 e 150 lire.
Ma nonostante ciò, il fenomeno continuò. Le banche reagirono facendo leva sul consenso sociale: i miniassegni funzionavano, risolvevano un problema quotidiano e nessuno voleva rinunciarvi. Alcuni magistrati, come quello di Milano, finirono per archiviare i procedimenti, sancendo di fatto una tacita legalizzazione dell’illegalità.
Intanto, le banche ci guadagnavano enormemente. Il miniassegno era formalmente un titolo di credito, ma nessuno li riscuoteva: la carta era scadente, si strappavano facilmente, si rovinavano e molti finirono distrutti. Altri vennero tesaurizzati da collezionisti o dimenticati nei cassetti. Il risultato? Le banche non dovettero mai onorare la maggior parte dei miniassegni emessi. Era denaro gratuito entrato in circolazione, senza copertura reale e senza obbligo di rimborso.
Questo squilibrio tra diritto formale e pratica diffusa è straordinario. Come nella nascita delle criptovalute, anche i miniassegni furono generati da un bisogno reale: l’impossibilità di effettuare transazioni con piccoli importi. Ma mentre Bitcoin e simili rivendicano oggi una legittimità fondata su tecnologie decentralizzate, i miniassegni erano il frutto di un sistema bancario accentrato, che agiva in aperto conflitto con le prerogative dello Stato.
A ben vedere, i punti di contatto tra miniassegni e criptovalute sono numerosi: entrambe le forme monetarie sono nate in assenza di controllo centrale, entrambe sono state accettate dalla collettività prima ancora che dalla legge, ed entrambe hanno creato un’illusione di stabilità che, a un certo punto, ha rivelato i suoi limiti.
C’è anche una differenza radicale, però: mentre le criptovalute sono oggi tracciabili, codificate e difese da sistemi crittografici, i miniassegni erano fragili, impersonali, facilmente falsificabili. Esistevano perfino delle serie turistiche a tiratura limitata, destinate al collezionismo e vendute a caro prezzo. Il collezionismo stesso divenne mercato parallelo, con nomi in codice per identificare le emissioni più rare – “il Salento”, “il Sella Lungo”, “il Levi”.
Nel caos, la funzione monetaria dei miniassegni finì per coprire l’illecito con l’utilità. Nessun commerciante poteva rinunciare a dare il resto. Alcuni esercenti, come i cinema, ne facevano uso sistematico. La Banca Sella, che fu tra le prime a emetterli, arrivò a personalizzare i miniassegni per singole attività commerciali, con tanto di loghi e firme stampate. Era diventato anche uno strumento di marketing. Non vi fu città italiana in cui non circolassero miniassegni, dalle macellerie ai bar, dai giornalai alle gelaterie.
Fu solo con il ripristino della coniazione regolare da parte della Zecca che i miniassegni iniziarono a sparire. Nel 1978, il Ministero delle Finanze riuscì a ristabilire la normale circolazione monetaria e il fenomeno cessò. Ma l’esperienza lasciò molte domande aperte, e un monito ancora attuale: quando la moneta sfugge al controllo pubblico, il rischio è che l’economia si trasformi in un teatro di illusioni, dove la legge viene sospesa in nome dell’emergenza, e dove i più forti (le banche, allora) ottengono il massimo vantaggio.
Oggi, nell’era del digitale, vediamo fenomeni simili riproporsi sotto nuove forme. Le criptovalute vengono emesse senza garanzia statale, accettate da milioni di utenti, spesso non convertibili in denaro legale e soggette a sbalzi di valore, furti informatici, perdite irreversibili. Proprio come accadde con i miniassegni: una corsa alla fiducia che nasconde un rischio sistemico.
La lezione, forse, è che ogni forma di denaro alternativo nasce sempre da un vuoto: normativo, tecnico, fiduciario. Ma se non regolata, può degenerare in speculazione, opacità e disuguaglianza. I miniassegni furono il passato illegale della moneta, le criptovalute rischiano di essere il futuro anarchico.
E in mezzo, come sempre, ci siamo noi: cittadini, utenti, consumatori. Che barattiamo regole certe con soluzioni facili, senza sapere davvero chi ci guadagna. Allora le banche. Oggi?